Sharing economy
v/s Gig economy
Che cos’è la sharing economy?
Una serie di pratiche di scambio e di condivisione ascrivibili all’interno di un modello economico in teoria alternativo rispetto al precedente consumismo di massa, ponendo l’accento sulla riduzione dell’impatto sociale e ambientale. L’altro principio su cui si basa è la valorizzazione economica di ciò che è ancora improduttivo.
L’economia della condivisione interessa diversi settori e ha un suo vocabolario specifico:
| coworking | crowdfounding | bikesharing | couchsurfing | delivery | crowdsourcing, la banca del tempo |
| il settore dei beni e dei servizi |
la finanza | la mobilità | il turismo | la logistica | i saperi |
L’economia collaborativa spesso viene confusa con l’economia della rendita: la prima è una forma diffusa di interazione tra persone che si scambiano beni, servizi e lavori in un coworking, in una cooperativa, in un’impresa sociale o in una fabbrica occupata; la seconda, invece, indica il nuovo modello del capitalismo. Dietro la retorica neo-comunitaria sulla collaborazione, la disintermediazione, la creatività e la libertà emerge il più classico dei modelli di mercato.
Una ricerca del 2016 della Foundation for European Progressive Studies (FEPS) ha sostenuto che in Gran Bretagna sono 5 milioni i lavoratori pagati dalla cosiddetta gig economy, erroneamente confusa con la “sharing economy”. Tre milioni sono regolarmente impegnati nella nuova economia dei servizi. Più di un quarto (26%) dei crowd-workers sostiene di guadagnare metà del proprio reddito annuale attraverso le piattaforme online. Il 21% ha usato le piattaforme per cercare un lavoro digitale pagato. Il 42% considera la piattaforma come una necessità quotidiana: parliamo di tassisti, lavoratori edili, graphic designers, contabili.

È probabile che la decisione di rinviare le linee guida europee in materia sia stato il primo risultato di queste pressioni, nello scenario attuale incerto nel quale non sono ancora noti gli orientamenti comunitari soprattutto sulla materia fiscale e commerciale. Anche il progetto di legge italiano si preoccupa di far pagare le tasse: sarà l’Antitrust a regolamentare e vigilare su un settore considerato solo nella sua dimensione commerciale e non come cooperazione sociale tra freelance che agiscono in un’economia mutualistica. Le piattaforme presenteranno la loro «policy» ogni anno, l’Antitrust procederà alla loro iscrizione in un registro nazionale. Il modello regolatorio dall’alto, invece basato sulla reputazione, si spiega con l’esigenza di istituire un modello fiscale per le multinazionali dei servizi online e garantire i consumatori. Lo “sharing economy act” riproduce la mentalità diffusa nella “società a costo marginale zero”: i datori di lavoro e i lavoratori sono tutti produttori-consumatori (prosumers). L’attività di nessuno, ufficialmente, viene riconosciuto come lavoro. In realtà, chi eroga una prestazione non ottiene in cambio il riconoscimento dei diritti di un rapporto di lavoro.
Che cos’è la gig economy?
E’ l’economia dei mini jobs dei servizi on demand. Investe soprattutto il settore dell’intermediazione attraverso la gestione di una piattaforma digitale, che rappresenta l’interfaccia strutturale dell’azienda con la quale utente/cliente, altre imprese e il lavoratore vengono coordinati in un piano strutturale che, si dice, genera contatti e valore. Secondo questo modello non esistono più prestazioni d’opera continuative, ma “a chiamata”: solo quando il mercato ha bisogno di un servizio produce occupazione; il collaboratore mette a disposizione capacità e competenze in base alla richiesta. Domanda e offerta vengono gestite per mezzo di app, siti internet e piattaforme dedicate. Gli impiegati in questa economia sarebbero tutti freelance che lavorano in proprio (self - employed), svolgendo attività temporanee (part time, saltuarie).
Gli attori
L’azienda [Foodora]
Foodora è una startup tedesca operante a Mfailano, Torino, Roma e Firenze. Appartiene alla famiglia delle cosiddette aziende “innovative” fornendo ai ristoranti un sistema di consegne take away basato su ordinazioni fatte per mezzo di un’app per smartphone. Foodora viene fondata con il nome di Volo GmbH a Monaco di Baviera nel 2014. Quando viene acquistata da Rocket Internet nell'aprile 2015, la società cambia nome e si trasferisce a Berlino. Nel settembre 2015, Delivery Hero acquisisce Foodora da Rocket Internet (di cui è una partecipata al 30%).
Il proprietario di Foodora è una società del nord Europa che ha sede a Berlino. Fondata inizialmente in Svezia nel 2008 da Niklas Ostberg si è espansa fino al 2011 diventando Delivery Hero Network. Attualmente il suo valore è di 3,1 miliardi di dollari, opera in 33 paesi; conta almeno 3000 dipendenti e migliaia di lavoratori in bicicletta; i ristoranti affiliati sono 271.000 circa e i clienti 17 milioni per una cifra di 127 milioni di ordini.
Viene inaugurata la prima sede italiana di Foodora a Milano il 10 agosto del 2015. Diretta da due ragazzi classe '87 '88. Coinvolge circa 200 lavoratori nel capoluogo piemontese e circa 300 in quello lombardo. Vive un periodo di forte espansione: gli ordini sono aumentati del 75% in un anno. Si stima che i lavoratori foodora abbiano coperto la distanza di 295.000 chilometri (9 volte il giro intorno alla Terra).
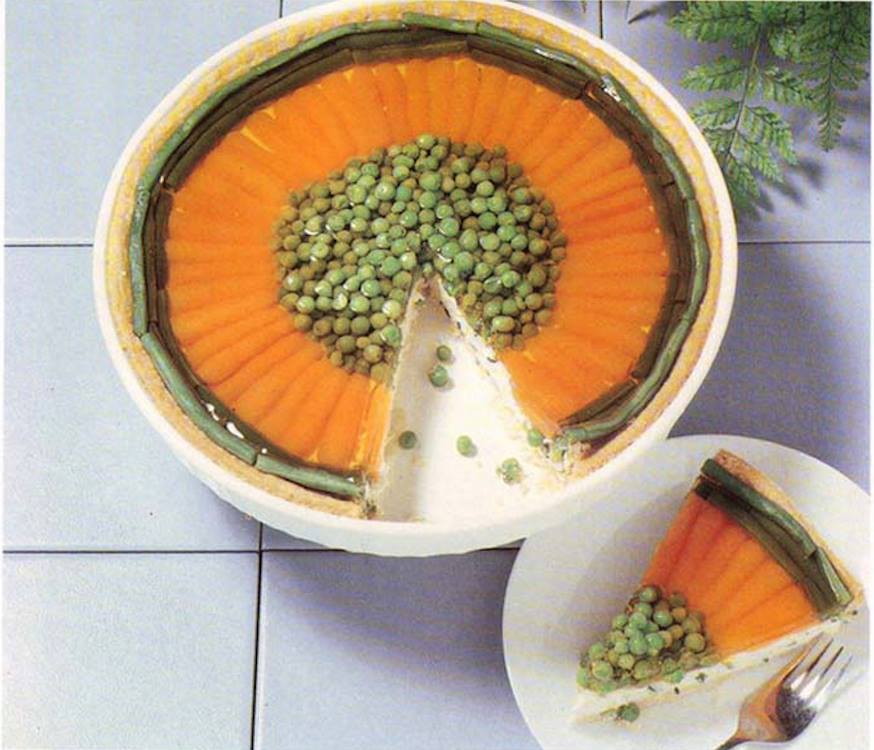
E’ una società che fornisce un doppio servizio sia di B2B che di B2C.
Business-to-business è un’espressione inglese che più specificamente indica le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori per attività di approvvigionamento, di pianificazione e monitoraggio della produzione o di sussidio nelle attività di sviluppo del prodotto, oppure le relazioni che l'impresa detiene con clienti professionali, cioè altre imprese, collocate in punti diversi della filiera produttiva.
Con Business to Consumer, spesso abbreviato in B2C, si indicano le relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi clienti per le attività di vendita e/o di assistenza. Questa sigla è utilizzata soprattutto quando l'interazione tra impresa e cliente avviene tramite internet, ovvero nel caso del commercio elettronico. Gli intermediari online sono le aziende che facilitano le transazioni tra clienti e venditori, ricavando una percentuale dal valore della transazione stessa. Costituiscono attualmente la maggior parte delle aziende operanti nel B2C.
Le consegne vengono materialmente effettuate da una una flotta di rider, lavoratori in bici o motorino, che ricevono le commesse attraverso la versione dell’app progettata da Foodora stessa, per lo smistamento e l’assegnazione.
In Italia, la piattaforma di cibo a domicilio viene lanciata a Milano nel luglio 2015 e a Torino nel settembre 2015. Foodora fornisce ai ristoranti un sistema di consegne take away basato su ordinazioni fatte mediante applicazione (app) per smartphone.
Foodora è una multinazionale che opera a livello internazionale in 10 paesi e per più di 5000 ristoranti: Austria, Canada, Australia, Germania, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Una delle strategie nella gestione delle risorse “disumanizzate” più gettonate è il dumping un anglicismo utilizzato per indicare la pratica di alienare un bene su un mercato estero a un prezzo minore rispetto a quelli messi in atto sul mercato di origine. La lotta dei riders italiani della Foodora si inserisce in questo contesto globale. Nel loro caso si discuteva sia dell’entità del compenso a consegna, passata da 6,5 euro lordi a 2,70 (in Francia e Germania Foodora paga 7), sia sulla natura del contratto di lavoro.
I Riders
Il lavoratore non deve diventare parte attiva del processo, deve solo eseguirlo secondo regole prestabilite, in quanto il lavoratore è un utente come tutti gli altri: allo stesso modo di un utente-consumatore, accede alla piattaforma e da quel momento la sua prestazione lavorativa diviene istantaneamente merce. Liberi professionisti, che scelgono volontariamente tempi e ore di lavoro questa è l’ingannevole definizione dei rider data da Foodora: l’azienda si racconta dipingendo i lavoratori alla stregua di ragazzini che consegnano giornali per rimpolpare la paghetta settimanale, quando in realtà è ben consapevole di pescare i rider in quell’enorme esercito di sottopagati o disoccupati, giovani, studenti, precari, costretti ad accettare condizioni di lavoro massacranti per infime paghe. Lo slogan dovrebbe essere tramutato in Stay alive! viste le ben note difficoltà di chi si muove in bici tra le arterie congestionate della città, durante le condizioni climatiche più svariate, in costante lotta contro il tempo per non consegnare in ritardo.
Il continuo uso di un lessico basato sull’innovazione, sul feticcio delle nuove tecnologie, “smart work in the smart cities for smart people” serve a creare una barriera ideologica in difesa dei modelli predatori sublimati nell’idea di sharing. Lo stesso termine di sharing è fuorviante: cosa c’è di condiviso nel mettere a valore il proprio tempo e il proprio lavoro? È così ampia la differenza tra un rider e un facchino o un generico lavoratore della logistica? I fattorini in bici sono il simbolo di una nuova logistica urbana sostenibile. Vanno in bicicletta. Sono ciclisti-lavoratori che non inquinano e vestiti in modo vistoso, con colori sgargianti e vivaci colorano il paesaggio urbano di sfuggita, inafferrabili, atomizzati, stilosi e brandizzati. La loro condizione è segnata da un profondo sentimento di solitudine e di parcellizzazione. Si percepiscono come self imployed anche se in realtà devono sottostare alle direttive della società con cui lavorano, ma non hanno occasione di incontro con gli altri “colleghi” salvo alcune zone che vengono considerate punti di snodo, in cui si sosta tra una consegna e l’altra, nei momenti di stanca.
Ristoratori
Sono i ristoranti che decidono di disporre del pacchetto offerto dalla società di intermediazione digitale per il servizio di promozione e consegna. In cambio concedono una percentuale fissa del loro guadagno che va dal 25% al 35%.sulla singola consegna. Il ristoratore in questo modo decide di investire su un’implementazione del proprio mercato, virtuale e digitale, perché non ha la certezza di quanto gli frutterà, ci sono solo le stime del mercato in crescita di Foodora, che è un’azienda in crescita, ma al quale sviluppo di mercato non coincide per forza l’incremento di ogni singolo gestore dell’esercizio commerciale che decide di connettersi al suo network. Di certo la percezione è quella di potenziare la propria visibilità sociale finendo su una piattaforma digitale per inseguire un’offerta di servizio che sia in grado di adattarsi alle trasformazione del mercato, alla sua flessibilità e che si propone come soluzione rigenerante in risposta alla flessione della domanda nell’economia dopo la crisi. Il food è un settore sicuramente strategico, ma è un dato di fatto che in questo ambito tanti aprano quanti ne chiudono. C’è un continuo ricambio di ristoranti e una forte mobilità urbana rispetto a dove si collocano, soprattutto se si prende in considerazione l’altro fenomeno significativo del settore che è l’esplosione dello street-food in città, anche questo visto da parte dell’esercente come opportunità di “fare impresa” investendo i soldi un capitale di partenza relativamente limitato per l’apertura di un piccolo biroccino ambulante che possa rappresentare un dispositivo di riorganizzazione nel mare magnum della disoccupazione.
Di sicuro l’economia del delivery food ha tutte le caratteristiche per essere classificata come una di quelle attività che si articolano su logiche di un’economia della promessa. Si finisce su una piattaforma che è un aggregatore di punti di interesse che garantisce visibilità relativa e una pubblicità che si paga ogni volta sul canone della consegna, nella tariffa.
Uno degli aspetti più rilevanti da evidenziare è che i ristoratori si organizzano in base a quel tipo di guadagno e diversifica il prodotto tenendo conto della percentuale sottratta sul prezzo di listino. Nella fase di pricing comunque il gestore concerta con la società che fornisce il servizio per mezzo del suo agente di commercio che gli espone i trend di mercato.
Clienti-Utenti
Utilizzando il sito internet della società o l'applicazione per i dispositivi mobili, i clienti visualizzano i ristoranti vicino a loro e possono fare un ordine, pagando online. L'ordine viene preparato dal ristorante, ritirato dal corriere e consegnato al cliente finale, entro 30 minuti, o almeno questo è quanto viene dichiarato sul sito o nella presentazione dell’app nel momento in cui viene scaricata dallo store. La promessa è quella della comodità, del confort e della velocità, oltre che della garanzia sulla qualità del servizio. In realtà le cose non stanno proprio così, visto le condizioni igienico-sanitarie, spesso i ritardi si accumulano durante le attese interminabili di fronte ai ristoranti, soprattutto negli orari di punta, che sono i momenti in cui fioccano il maggior numero di ordini. Chi usa questo tipo di servizi? Non sono usciti ancora dati interessanti e studi di settore specifici, perché si tratta di un settore giovane, benché la figura del pony-express sia un’immagine piuttosto novecentesca. Dalle prime indagini l’avatar che corrisponde all’utente medio è un millennials che ha un rapporto quotidiano e disinvolto con la tecnologia collocabile in una fascia anagrafica che va da 29 ai 35 anni. Seguono a ruota i giovanissimi dai 15 ai 25 anni, appartenenti alla generazione Z, coloro che sono cresciuti durante la fase social, e la generazione X, soprattutto se cittadini e aventi un titolo di scuola di media superiore e quindi un rapporto con internet e la filosofia smart più prossimo. La consegna al singolo utente costa il 2,90 di base. Ad essa vengono poi applicate delle variazioni in base alla fascia oraria, se la richiesta è fatta dopo l’orario di massimo traffico di ordinazioni, quando meno rider sono disponibili. Il maggior numero di consegne viene effettuato nelle zone centrali della città. In zona 1 o nelle sue aree limitrofe. Questo ci dice che è un servizio partito come servizio di lusso che sta cercando di radicarsi come fenomeno di costume per allargare e diversificare il proprio target. Lontano però dall’ottica della cucina gourmet la maggior parte dei pasti consegnati sono sushi dozzinale, pizza, hamburger e cibo cinese.
Domande di ricerca
Algoritmo al potere?
Appare evidente come il problema non sia tanto l’entità della remunerazione, quanto la mancanza di trasparenza e controllo dell’organizzazione delle prestazioni lavorative, soggetta alla supposta neutralità algoritmica o a politiche aziendali attuate. La mediazione della piattaforma rende opaco il rapporto tra le parti, lo riduce ai minimi termini, tanto che il presidente di Amazon Jeff Bezos, lanciando il servizio pioniero del crowdworking Amazon Mechanical Turk, lo definì come l’inizio dell’ “humans-as-a-service” o “human API”.
Un processo di selezione basato quasi esclusivamente sul rating, il giudizio collettivo che accompagna ogni lavoratore all’interno della piattaforma, strumento di regolamentazione e controllo del mercato delle piattaforme; esso è fondato sulla concezione per cui il voto collettivo è sinonimo di autenticità e affidabilità della misurazione della capacità di un lavoratore. Per falsificare questo assunto basta considerare come ad un servizio come quello di TripAdvisor, che si basa sulla pubblicazione e diffusione di recensioni per alberghi e ristoranti, sia collegato un fiorente mercato di compravendita di recensioni fasulle che permettono di aumentare artificiosamente il proprio rating o diminuire quello dei concorrenti (le ultime quotazioni danno il costo di una recensione tra i 2 e i 4 euro).
Non esiste nemmeno nessuna garanzia che questo meccanismo del consenso punisca comportamenti non corretti. L’aleatorietà del rating facilita persino fenomeni discriminatori: un basso rating facilita la disparità di trattamento, come già successo per Uber o la concorrente Lyft accusate di permettere di escludere disabili dalle proprie corse, o per Airbnb dove vengono applicate tariffe più elevate per utenti dai nomi poco occidentali. Senza tenere conto che due colpetti sullo schermo di uno smartphone bastano per ridurre il rating ad un lavoratore che si vede scavalcare dai “colleghi”, mettendo a repentaglio la sua presenza sul mercato sino alla sua espulsione per rating troppo basso. Un ban, una disconnessione dalla piattaforma, equivale ad un licenziamento immediato, alla portata di un click, come è accaduto a due lavoratrici Foodora ritenute conniventi con le proteste di Torino. Il licenziamento facile del Jobs Act sembra già un relitto preistorico.
Google si è affidata ai lavoratori dei dati (data workers) per “allenare” gli algoritmi che permettono anche alla Google Car di fare tutti gli incidenti che vuole e di provare ad evitarli. L’azienda, com’è noto, rifinisce in continuazione la sua ricerca degli algoritmi attraverso la guerra per il posizionamento nel ranking: i suoi ingegneri si affidano a lavoratori chiamati “raters” – cioè contrattisti che spesso lavorano ai Pc nelle loro abitazioni – per valutare la ricerca delle pagine e per classificarle. I “classificatori” possono inquadrare le pagine come “vitali”, “utili”, “abbastanza rilevanti” o “spam”. Dopodiché, gli ingegneri Google “importano” queste valutazioni nel loro algoritmo, per permettergli di comportarsi come i lavoratori da casa. L’esempio è utile per raccontare l’emergenza dell’industria del micro-lavoro digitale, che a sua volta costituisce il vero nucleo dell’intelligenza artificiale – la forza lavoro, il lavoro vivo di cui parla Marx.
L’automazione genera nuovi lavori: possono essere modesti e servili, come anche creativi e avanzatissimi. Le multinazionali tecnologiche producono nuovi tipi di dati, linguaggi, immagini, suoni. Facebook, YouTube i dati prodotti con gli smartphone, sono riprocessati e classificati dai micro-lavoratori. I micro-lavoratori supportano gli algoritmi nell’apprendimento di comportamenti da adottare in ambienti umani. Semplificano cioè il processo di grandi quantità di dati, in modo tale da processarli in altre maniere: siedono davanti a terminali e trascrivono piccole clip audio, inserendo testi destrutturati nei database; moderano commenti; allineano le inserzioni Google o Facebook rispetto ai profili degli utenti; guidano gli algoritmi secondo una determinata cultura o una serie di indicatori culturali predisposti fuori dall’automazione, in modo tale che l’automazione prenda la forma richiesta. E così via.
Questo è il lavoro nascosto che permette a queste compagnie di sviluppare prodotti “intelligenti” e macchine che auto-apprendono. La “nuova rivoluzione”delle macchine non riconosce il lavoro di cui si nutre, senza contare il lavoro degli utenti che cooperano per migliorare la performatività degli algoritmi messi all’opera nella loro vita quotidiana. Nell’economia politica computazionale questo lavoro è centrale, e tuttavia non viene pagato se non nell’ordine di pochi centesimi per operazione. È il paradosso del lavoro gratuito. Un lavoro così invisibile che a nessuno viene in mente che lo si possa anche retribuire. Chi lo accetta non ha alternative, spera in tutt’altro, ma è costretto a farlo per il tempo necessario. Accade questo in una società in cui il denaro è importante, ma si fatica sempre di più ad ottenerlo da un’enorme quantità di attività lavorative che hanno perso valore.È in atto una continua sottrazione di salario basato sul giudizio sulla qualità vera o presunta della prestazione che deve soddisfare le esigenze del cliente. Il ranking di quel lavoratore – lo stesso che il cliente ignaro fornisce quando riceve il servizio o il bene richiesto online – è lo strumento di una lotta di classe a base di classifiche, giudizi, certificazioni. L’automazione non è un problema in sé. Lo diventa quando viene intesa come il principale fattore che cancella il lavoro umano, ma essa stessa è il prodotto di una forza lavoro intellettuale e manuale. Ma questo è il minimo: il problema sta nella rappresentazione stessa del lavoro oggi. La sua opacità è il risultato della liquidazione della forza lavoro, cioè la soggettività di chi vive e lavora. Viene fatto credere che nel capitalismo delle piattaforme non ci sia spazio per il lavoro, e che il futuro è il frutto di una macchina anonima governata da algoritmi intelligenti. La macchina mitologica funziona a pieno ritmo e ha generalizzato il feticismo della merce nel mondo digitale: l’unico rapporto sociale possibile è quello fantasmagorico tra le cose, le macchine, gli algoritmi.
Cottimo
Pagamento a consegna per prestazione d’opera. Al lavoratore in piena salsa postfordista viene chiesto di assumersi tutti i rischi della fluttuazione del mercato, in virtù del suo inquadramento giuridico che lo vuole come lavoratore autonomo, nei panni del collaboratore freelance che lavora come esterno all’azienda e non come subordinato mettendo a disposizione i propri mezzi (smartphone, bicicletta, corpo). Il disegno è quello di scaricare tutti i costi sulla flotta di fattorini che diventano i cuscinetti a discapito dei quali la società resta in grado di garantirsi come organismo parzialmente autoimmune da eventuali flessioni in un’ottica di risparmio che la salva da eventuali rischi di indebitamento, la società si struttura come organo “salva-valore”. Non a caso i primi contratti in fase di startup si basano su una forma di pagamento che riconosce una tariffa oraria, ma in un seconda momento, sulla base di una narrazione improntata sulla meritocrazia viene introdotto il cambio di contratto con l’inserimento della modalità di pagamento a consegna, in modo tale che il lavoratore sia in grado di guadagnare di più. In realtà quello che accade è che in questo modo le ore messe a disposizione negli slot deboli non vengono remunerate, perché restano non valorizzate in assenza di ordini. Dovrebbe esserci il riconoscimento del tempo della messa a disposizione. E centrale entro questi termini resta la questione del salario minimo, che è anche stata una delle molle nelle proteste estere che hanno caratterizzato le vertenze nel settore. I fattorini di Deliveroo, piuttosto che i driver di Uber, percepivano uno stipendio che era al di sotto del salario minimo. Questo ha rappresentato il grimaldello ideologico che ha scatenato l’agitazione tra i lavoratori, insieme alla minaccia del passaggio al cottimo. Un’altra questione che resta aperta sul cottimo è la differenziazione chilometrica. Se ad un rider capita di dover fare una consegna di molti chilometri (molti in più rispetto a quelli che vengono presentati in fase di colloquio, in cui si dice al lavoratore che la distanza max che andrà coperta sarà di 2 chilometri). E’ innegabile che la battaglia sul cottimo va fatta, anche se sfortunatamente, per come si dispone l’organizzazione del lavoro all’interno di quel mercato può divenire addirittura controproducente per il lavoratore stesso e nuova occasione di risparmio per l’azienda, perché può innescare strategie di riassetto della flotta. Per questo motivo va affrontata in maniera problematica, studiando in maniera organica anche nuove forme di integrazione tra diritto, rimborso e di riconoscimento del salario.
Contratto
Relativa copertura infortunistica (attraverso inail e previdenza privata, a copertura dei casi più eclatanti), malattia non riconosciuta, tariffe e organizzazione del lavoro modificati senza preavviso e poco trasparenti, assenza di canali di comunicazione con i vertici aziendali. È in questa visione che acquistano senso nuovo, oltre la classica tradizione antisindacale, le parole dei due amministratori di Foodora, Gianluca Cocco e Matteo Lentini, quando si dicono disposti “ad ascoltare i ragazzi, non collettivamente, ma face to face”. Non a caso i «gig workers» si sono organizzati in class action. Anche se è innegabile che Foodora ha potuto beneficiare del Jobs Act che gli consente l’uso dei co.co.co. Il caso di Foodora è un altro guaio creato dal Jobs Act, che aveva promesso di combattere la precarietà e invece la alimenta. Ad avere parlato di un «paradosso del Jobs Act» è stato Maurizio Sacconi, presidente della Commissione lavoro del Senato, dopo l’audizione del direttore generale dell’ispettorato nazionale del lavoro Pennesi sul caso Foodora, e sui lavori da piattaforma digitale. La riforma Renzi ha cancellato i contratti a progetto ai quali si applicava il riferimento ai contratti collettivi dei lavoratori subordinati. Come effetto sono riemersi i contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è difficile stabilire parametri di equo compenso. I lavoratori di Foodora rientrano in quest’ultimo caso, messo a disposizione dalla legislazione vigente. «Ora solo un accordo collettivo potrebbe definire in termini più congrui il rapporto di lavoro di questi prestatori d’opera. D’altronde lo stesso progresso tecnologico sarà più fluido se non proporrà forme di abuso del lavoro» sostiene Sacconi. Lo stipendio offerto da Foodora è chiaramente non adatto alla sopravvivenza, raramente supera i 4-500 euro al mese. Il contratto stipulato però che è una collaborazione coordinata continuativa con chiare connotazioni da contratto di lavoro subordinato nei processi di organizzazione del lavoro. Foodora segue un principio neo taylorista: frammenta il processo e i tempi del lavoro, occupa personale perfettamente sostituibile che è privato del tutto del controllo sul processo e sul tempo lavorativo. Queste “condizioni” permettono all’azienda di risparmiare su alcuni costi di gestione che finiscono per pesare sul lavoratore in termini di soldi, di tempo e di precarizzazione, lo stato è connivente perché ragionando altrettanto su risparmio della copertura di indennità offre una tutela forfettaria con la naspi, il che ha sicuramente esteso in maniera parziale potenzialmente il raggio d’azione del welfare sino a poco tempo fa inesistente su queste forme di contratto, ma di fatto rende più difficile il loro utilizzo perché il lavoratore è così flessibile e precario che guadagno troppo poco per abbandonare il lavoro ed è così temporaneo da pensare di cercarsi altro in partenza e si dispone nei confronti del proprio impiego con l’idea che deve trovare un’alternativa.
Ma è tutto perduto?
[3C]
Cospirazione Cooperazione Conflitto
Le esperienze di Uber e dei lavoratori di Deliveroo a Londra ci insegnano che non è affatto così. Di fronte ai nuovi modelli economici e alle nuove strategie di sfruttamento messe in atto dal capitale, i lavoratori non devono mai dimenticarsi che contro un datore di lavoro, che depriva in termini di diritto, salario, tempo, energie di vita e affettività, hanno sempre e comunque la possibilità di ribaltare la situazione se si creano le condizioni agitative adatte. I “non sindacalizzabili” si organizzano. In queste condizioni, da qualche tempo crescono gli esperimenti di auto-organizzazione. Per poter scardinare queste piattaforme è necessaria una critica all’ideologia della smartificazione del lavoro, che sappia smascherare come dietro la neutralità algoritmica ci siano precise scelte politiche e meccanismi di sottrazione, come il rating sia uno strumento di controllo privo di affidabilità e incapace di considerare tutti gli aspetti che sfuggono agli interessi predatori della piattaforma, come le opportunità fornite dalle nuove tecnologie siano assoggettate all’esercizio di controllo e di dominio del capitale. Per questo sperare in una regolamentazione di questi mercati da parte di qualche vetusta istituzione terza, o peggio riproporre anacronistiche visione luddiste, è dannoso proprio perché ci priva della possibilità di riconoscere le potenzialità liberatorie delle nuove tecnologie, negando a propri la creazione di mediazioni basate sul controllo collettivo da parte dei lavoratori e delle comunità in cui sono inserite. Scardinare le piattaforme significa quindi arricchire e svecchiare il conflitto con nuovi strumenti, nuove forme di sciopero, nuovi algoritmi che sappiano trasportare gli utenti-lavoratori e gli utenti-consumatori fuori dalla black box del capitale, verso piattaforme di mediazioni sociali controllate collettivamente per la produzione e la redistribuzione della ricchezza del comune. Il caso di Take it Easy in Belgio è emblematico. La startup fallisce.Take Eat Easy era una start up di consegne a domicilio che operava in venti città belghe e con la sua piattaforma metteva in contatto 3200 ristoranti. I bikers impiegati circa 4500. In un solo anno i clienti sono aumentati da 30 mila a 350 mila. Cifre vertiginose per un paese come il Belgio, ma non sufficienti per un’economia altamente finanziarizzata come quella della «gig economy». Adrien e Chloé Roose, co-fondatori di Take Eat Easy, hanno spiegato le ragioni del fallimento. La start-up si è sviluppata troppo lentamente e non è riuscita a trovare nuovi investitori. I fattorini a piedi. Senza welfare, si appoggiano a Smart, un’impresa di economia sociale composta da diverse entità con personalità giuridiche distinte e una fondazione che le coordina e ne garantisce il fine senza scopo di lucro. A gennaio Smart ha già deciso di trasformarsi in cooperativa e diventerà uno dei casi di riferimento per il dibattito mondiale sulla nuova cooperazione. Forte di 60 mila soci che versano il 6,5% dei guadagni in un fondo di garanzia in cambio di servizi, Smart è riuscita a sostenere il peso delle conseguenze del fallimento e ha allargato il numero dei soci. Smart aveva già siglato con Take Eat Easy, e con Deliveroo, un protocollo d’intesa che rimediava al principale problema del ciclo-lavoro a domicilio: il tempo di lavoro tra una corsa e l’altra non remunerato. Il protocollo ha assicurato un salario pari al minimo legale mensile in base alle ore lavorate, il rimborso delle spese di manutenzione per la bicicletta o le spese telefoniche e un’assicurazione contro gli incidenti. Il tutto nel quadro di un contratto di lavoro di cui Smart si è assunta le responsabilità del datore di lavoro. Nelle intenzioni dei promotori dell’operazione c’è il desiderio di «tutelare i lavoratori su base mutualistica dai rischi derivanti della discontinuità del lavoro indipendente, siano essi freelance o abbiano uno statuto “patchwork” come quello del lavoro nella gig economy.