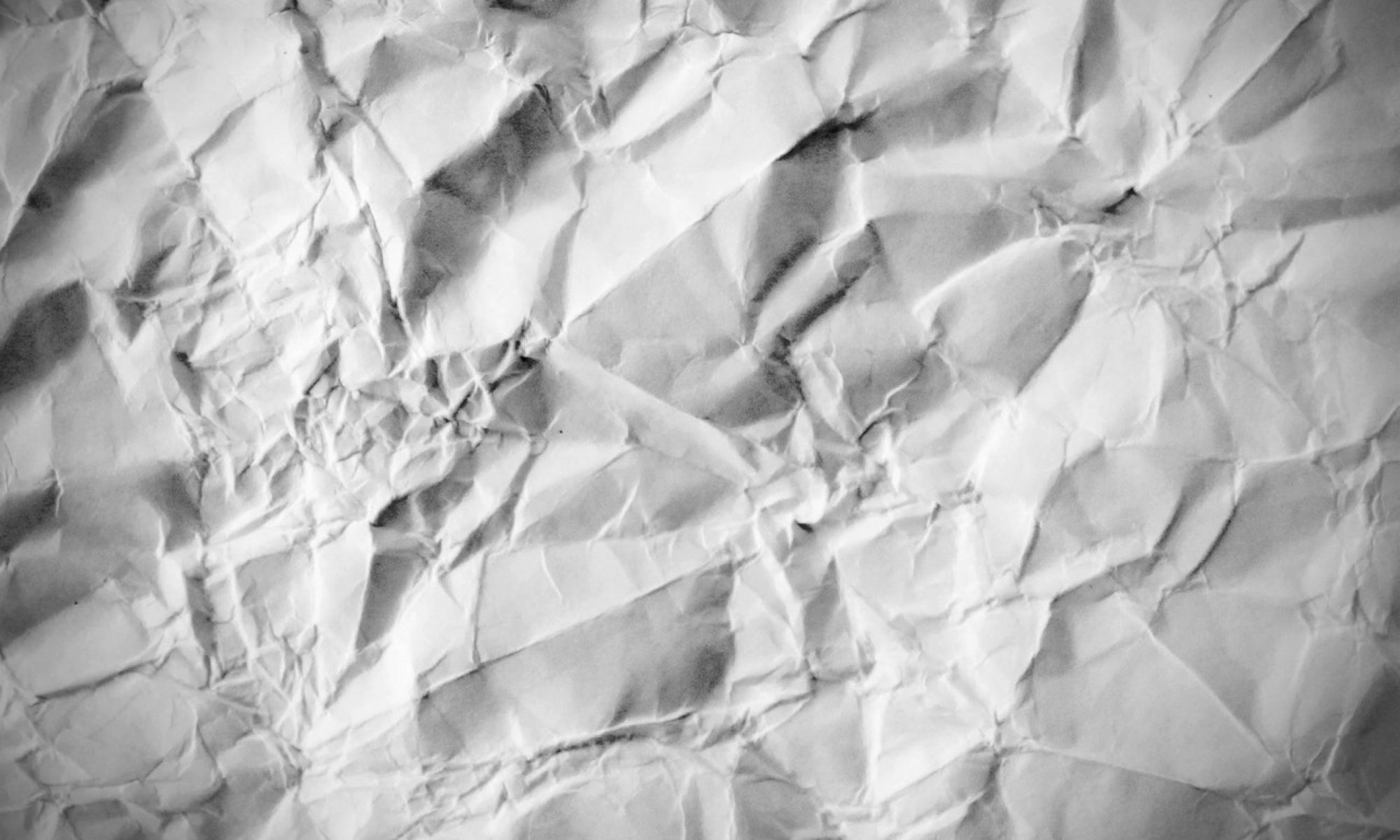Il prossimo 9 febbraio scenderemo in piazza – o meglio: saliremo, data la destinazione – nella tappa organizzata dal CIO milanese all’interno della mobilitazione nazionale La montagna non si arrende. A seguito dell’appello lanciato da APE Milano e poi fatto proprio dal CIO, appunto, sono diversi i territori che hanno risposto, per organizzare azioni e iniziative, marce e trekking nelle aree montane, in zone critiche interessate dalla costruzione di nuovi impianti di risalita dipendenti dall’innevamento artificiale o, peggio, dall’accanimento terapeutico che, tramite risorse pubbliche, tiene in vita infrastrutture private del turismo montano più tossico per ambiente e popolazioni. Non solo sui 450km di arco alpino colpiti dalle Olimpiadi Milano-Cortina, ma in tutte le Terre Alte del Belpaese.
La chiave della insostenibilità, con cui sin da subito come OffTopic e CIO abbiamo denunciato l’operazione dei Giochi invernali 2026, permette anche di chiarire qual è la contraddizione principale attraverso cui leggere il prossimo grande evento. Certamente, c’è quella città-montagna, cui bisognerebbe aggiungere anche il grande dimenticato, ovvero la provincia – dato che molte delle infrastrutture viabilistiche e stradali (oltre il 50% della spesa totale degli oltre 5 miliardi di spesa pubblica), inserite nel dossier olimpico, vanno a devastare territori agricoli e pastorali, in pianura e nelle vallate. Le Olimpiadi sono, infatti, un processo urbano: la montagna è sì trasformata in funzione di un flusso economico-turistico originato prevalentemente in città, la massa di persone, prevalentemente a reddito medio-alto e alto, che gode della lunga stagione invernale su piste da scii e località montane garantita dal consumo idrico attraverso i bacini di innevamento artificiale; o di consumatori saltuari di una montagna sempre più comoda da accedere, attraverso la moltiplicazione di parcheggi, strade, impianti di risalita.
Ma la stessa città è a sua volta modificata e trasformata nel proprio ambiente urbano per rispondere alle necessità del grande evento, che richiede anzitutto assenza di conflitto e pacificazione; pulizia sociale dei ceti meno abbienti e dei soggetti marginali; condizioni favorevoli alla crescita di un mercato immobiliare già di per sé deregolamentato, dove il mattone è finanziarizzato, in cui l’abitazione è interna al circuito turistico a breve termine; mentre il mercato del lavoro deve già essere sufficientemente flessibile – leggi: precario, dequalificato, stagionale, saltuario – per reggere il doping accelerato, quanto effimero, dei due mesi dei Giochi nei settori che lo reggono – ristorazione, alberghiero, eventi, turistico, beni culturali e artistici, marketing, logistica.
Ed è proprio questo il punto che rivela la reale contraddizione, che è quella sociale o, per usare una parolaccia, di classe. Certo, in una società stratificata non è semplice leggere tutte le linee di frattura, ma è ancora più difficile seguire chi legge il conflitto dietro una mega-macchina come quella olimpica come la contrapposizione tra ciò che fa bene in assoluto alla città e ciò che danneggia in assoluto la montagna – o come se ciò che avviene fuori dai confini metropolitani, nelle Terre Alte, non riguardasse gli abitanti delle città. Infatti, qui chi subisce le conseguenze delle trasformazioni territoriali realizzate per o con la scusa dei Giochi olimpici sono i ceti sociali più poveri e persino il ceto medio, che ha creduto a lungo di potersi in realtà inserire e beneficiare di un modello di accumulazione basato sulla crescita costante del costo di vita e case, così come di quelli ambientali e di salute dati da inquinamento dell’aria e consumo di suolo; mentre sulle Terre Alte, gli unici segmenti a godere di un modello di sfruttamento delle montagne che precede, informa e segue quello olimpico sono i padroni del turismo invernale e, fino a esaurimento scorte, tutto il ceto commerciante. Citando, infatti, l’incipit del report di Legambiente Nevediversa:
177 gli impianti temporaneamente chiusi nella Penisola (+39 unità rispetto al report precedente), di cui 92 sull’arco alpino e 85 sull’Appennino. Salgono a 93 gli impianti aperti a singhiozzo (+9 rispetto al report precedente), il grosso, ben 55, si concentra sugli Appennini. Altro dato in crescita è quello delle strutture dismesse che raggiungono quota 260 (erano 249 nel report precedente) di cui 176 sulle Alpi e 84 sulla dorsale appenninica; e quello degli impianti sottoposti al cosiddetto “accanimento terapeutico”, 241 quelli censiti da Legambiente (+33 unità) che sopravvivono solo con forti iniezioni di denaro pubblico. Il grosso, ben 123, sugli Appennini. Dati allarmanti a cui va aggiunta la crescita dei bacini idrici per l’innevamento artificiale: 158 quelli censiti (+16 rispetto al report 2023) di cui la gran parte in questo caso, ben 141, sulle Alpi, e il restante, 17, sulla dorsale appenninica. Sul fronte finanziamenti, per aiutare il settore sono ben 148 i milioni di euro destinati lo scorso anno dal Ministero del Turismo per l’ammodernamento degli impianti di risalita e di innevamento artificiale a fronte dei soli quattro milioni destinati alla promozione dell’ecoturismo. E se si guarda alle singole regioni si scopre che i finanziamenti per la neve artificiale non accennano a diminuire.
Proprio su questo, come Off Topic abbiamo curato e pubblicato Tracce, una contronarrazione visuale e dati alla mano per reimmaginare l’inverno dopo la crisi climatica del capitalismo: https://www.offtopiclab.org/tracce/
E’ dal nostro punto di vista evidente che, così come le Olimpiadi 2026 sono solo l’ultimo tassello all’interno di un processo di espulsione di chi è funzionale all’economia metropolitana meneghina solo in quanto forza-lavoro o cittadino-consumatore, ma che in quanto tale non serve che abiti nei quartieri riqualificati, allo stesso modo e peggio in montagna il sostegno all’estrattivismo e al saccheggio di risorse naturali e sociali non ferma lo spopolamento delle comunità montane, ma lo alimenta: drenando mezzi potenziali per la cura del dissesto idrogeologico e l’adattamento ai cambiamenti climatici; colpendo e impoverendo proprio chi lavora in quei settori economici esclusi e colpiti dallo sfruttamento imprenditoriale garantito ai padroni di Alpi e Appennini da centinaia di milioni di sussidi pubblici.
Per questo il 9 febbraio andremo tutt* a Bormio, tra i principali cluster di Milano-Cortina 2026* e luogo-simbolo di quel modello nocivo di devastazione delle Terre alte.
*le opere previste a Bormio riguardano i 31 milioni di euro per allargare la pista Stelvio e costruire un nuovo impianto di innevamento artificiale (oltre allo Sky Stadium da 12 milioni, una struttura in cemento che ospiterà le tribune per gli spettatori e la sezione di hospitality per gli ospiti “vip”), assieme a due interventi infrastrutturali: la cosiddetta “tangenzialina” di Bormio, progettata all’interno della piana agricola dell’Alute per un costo di oltre 7 milioni, e il cavalcavia del Trippi, impattante per chi vive nell’area, oltre ad essere particolarmente costoso (oltre 52 milioni). In particolare, queste ultime rientrano in quell’oltre 75% di infrastrutture viabilistiche con le Olimpiadi non c’entrano nulla e la cui realizzazione è prevista dal 2027 in avanti: molti cantieri, tra cui appunto “tangenziale” e Trippi, non sono ancora nemmeno aperti e la partita tutta da combattere.